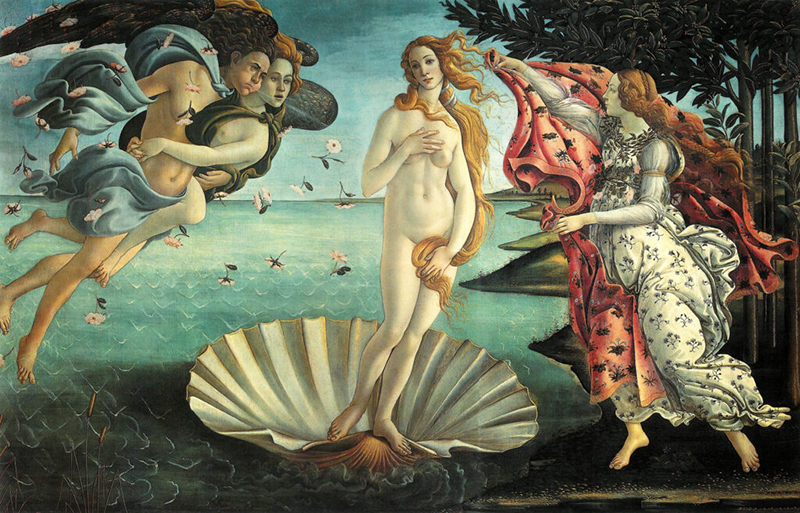Si è tenuto a Roma, il 10 dicembre 2021, l’evento formativo “Le dimensioni esistenziali del corpo e della psiche”.
Questo articolo si propone di riassumere gli interventi di relatori di fama internazionale che hanno preso parte all’evento promosso dalla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Umanistico Esistenziale con il patrocinio di Policlinico Italia, SIPO (Società Italiana di Psico-Oncologia), Istituto di Psichiatria di Ferrara e FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini).
Responsabili scientifici: Prof. Luigi Grassi e Dott.ssa Antonella Filastro
SESSIONE I: La voce silenziosa di un corpo che soffre
Dalla mente al corpo: il ruolo dell’Alexitimia nell’espressione somatizzata delle emozioni, Roberto Delle Chiaie
Alexitimia, dal latino a-lexis-thimos, ovvero mancanza di parole per le emozioni. Il termine è stato coniato da Peter Sifneos nel 1972 e viene usato per indicare difficoltà che l’individuo può manifestare nei processi di riconoscimento, comunicazione e descrizione delle proprie ed altrui emozioni. In generale, coloro i quali riscontrano queste difficoltà, faticano a distinguere ed associare la componente affettiva delle emozioni da/a quella viscerale. Per intenderci, il correlato viscerale della paura è l’accelerazione cardiaca e normalmente chi sente il cuore che batte forte dice “sono agitato”.
Molti studi presenti in letteratura hanno messo in luce come il fenomeno dell’alexitimia possa favorire la manifestazione di sintomi somatici quali: dolore toracico, dispepsia, disturbi digestivi (GAD) colon irritabile, dolore cronico pelvico, fibromialgia. Per quanto la prognosi di questi disturbi non sia infausta, essi impattano notevolmente sulla salute dell’individuo costretto talvolta a modificare le proprie abitudini e stili di vita.
Un aspetto interessante, che contribuisce a legittimare le richieste e il disagio portato dagli utenti, è l’amplificazione della sensibilità somatica, ossia l’amplificazione della percezione delle sensazioni corporee. Come spiegava il Dott. Delle Chiaie, tutti noi abbiamo una soglia di percezione delle sensazioni che derivano dal corpo (es. peristasi del tubo digerente). Se percepissimo tutte queste sensazioni vivremmo con un rumore di fondo costante. Ciò non accade in quanto esiste un filtro a livello del tronco encefalico dove passano a livello di corteccia parietale solo le sensazioni che superano un certo livello di sensibilità. Nelle persone che manifestano difficoltà a verbalizzare i propri vissuti emotivi si è rilevato un abbassamento del livello di soglia con una conseguente amplificazione della percezione delle sensazioni. Accade che la sensazione corporea viene percepita come sensazione somatica intensa, nociva e disturbante, e questo può favorire la tendenza a selezionare e focalizzare l’attenzione su sensazioni lievi e relativamente poco frequenti e a valutare sensazioni somatiche e viscerali normali come anormali, patologiche o come sintomi di una malattia.
L’intervento si è concluso sottolineando l’importanza di usare interventi che configurano il corpo come protagonista e di usare l’espressione corporea per favorire l’innesco di quella verbale.
Il disegno del corpo nella cronicità, Mara Lastretti
L’intervento della Dott.ssa Lastretti è stato volto a presentare un modello di intervento che viene usato per i pazienti con diagnosi di diabete e che ruota attorno al costrutto di “Patient Engagement”, portato in Italia dalla Professoressa Guendalina Graffigna. Considerando i limiti del modello medico “centrato sul paziente” che rischia di rendere l’individuo un utente passivo dell’agire medico scientifico, il modello “Patient Engagement” propone di configurare l’utente come risorsa che contribuisce a costruire il percorso di assistenza e cura grazie all’interazione con gli operatori sanitari e della salute e i familiari.
Da considerare che il diabete è una patologia ad andamento cronico e questo significa che i pazienti che ricevono questa diagnosi potranno prendersene cura non auspicando alla guarigione. Questa prospettiva futura è “ingombrante” nella misura in cui nega la possibilità di pensarsi “sani”, “persone guarite”, e, quanto meno inizialmente di pensare “a tornare alla vita di prima”. Il proprio corpo viene definito “fallato”; è un corpo che “ha tradito” e che manifesta una patologia che segna un “prima” e un “dopo” nella propria vita. Il modello “Patient Engagement” unisce 3 parti: sapere, saper fare e sapere essere. Il sapere medico, il saper fare del dietista e il saper essere dello psicologo. Lo psicologo offre un contributo rilevante nelle diverse fasi che caratterizzano i vissuti dei pazienti che ricevono una diagnosi di diabete sia in termini di valutazione sia in termini di intervento. Recenti studi hanno messo in luce come inserire lo psicologo all’interno dei percorsi di cura implica una riduzione dei costi in capo al Sistema Sanitario Nazionale (SSN), o meglio, implica una generazione di risparmio. Uno degli indicatori di efficacia di un intervento con pazienti che appartengono a questa popolazione clinica è la configurazione da parte del paziente del diabete come uno degli elementi che fanno parte della sua biografia. Ciò significa passare dall’uso del verbo “essere” all’uso del verbo “avere”: dal “sono malato” al “ho una malattia”.
La presenza dell’assenza. La rimodulazione della clinica nei momenti di criticità, Flora Gigli
L’intervento della Dott.ssa Gigli è stato volto a mettere in rilievo in che modo la diffusione del Virus SARS-Cov-2 ha cambiato le dinamiche interattive con i pazienti all’interno di un setting di oncoematologia pediatrica.
Ci troviamo di fronte a pazienti sorretti da un corpo ferito. Un corpo che quotidianamente viene esposto e sottoposto a manipolazioni invasive, esami, medicazioni. Il corpo subisce delle modifiche, è un corpo da proteggere che limita l’interazione in quanto questa può rappresentare un rischio nella misura in cui l’altro può essere veicolo di contagio, del virus ad esempio. Il Covid, infatti, ha estremizzato le difficoltà interattive là dove il lavoro principale è d’integrazione tra mente e corpo. La Dott.ssa Gigli chiedeva: com’è possibile stare in una stanza senza toccarsi? Guardarsi negli occhi e non sentire l’odore dell’altro e cogliere quelle sfumature che sono parte integrante della relazione terapeutica. Interagire attraverso l’uso di uno schermo cambia ed altera dimensione fondamentali dell’interazione umana.
La Dott.ssa ha parlato di “vivere l’ingombro della presenza”: “la presenza del corpo è un ingombro incredibile. Il corpo pesa perché sono pazienti feriti, sono gonfi, malati… Il corpo c’è. Questo significa che se la presenza è ingombrate, impegna i nostri sensi, impegna il nostro tempo. Il corpo pesa anche dal punto di vista temporale. È una dimensione di grande valore e molto spesso non ci siamo resi conto di quanto dia senso e significato a quello che in quel momento stiamo facendo”.
SESSIONE II: Il corpo di fronte all’incertezza
Il corpo nella malattia oncologica, Alessandra Fabi
“Anche se sono destinato a morire di questo cancro, almeno vivrò”
L’intervento della Dott.ssa Fabi è stato volto a mettere in luce come sia necessario considerare la cornice contestuale, culturale e individuale entro il quale si inserisce il percorso di cura di donne che ricevono una diagnosi di tumore. Cornice in costante mutamento.
“Siamo in una fase di medicina di precisione, personalizzata: ogni paziente ha la sua cura, ma non solo: ogni paziente ha una sua necessità, diversa dall’altro”. Il senso e il significato attribuito ai sintomi e ai cambiamenti secondari alla malattia sono strettamente connessi all’universo simbolico dell’utente. Ad oggi, infatti, si parla ad esempio di “effetti collaterali soggettivi”.
Il mutamento culturale si manifesta dal cambiamento delle priorità: dalle ultime analisi condotte emerge come sia la qualità della vita la dimensione che maggiormente vuole essere tutelata.
La domanda più frequente da parte di chi riceve una diagnosi di tumore è “quanto mi rimane da vivere?”.
La seconda domanda è “cosa posso riuscire a fare nel corso del trattamento?”.
Per quanto la medicina stia progredendo anche dal punto di vista dei trattamenti e per quanto si stia sempre più prendendo cura della dimensione “qualità della vita”, la chemioterapia rappresenta per la donna il momento più critico proprio per ciò che comporta a livello di effetti collaterali e cambiamenti che inficiano nell’immagine corporea e nell’immagine di sé, nell’identità, nel proprio ruolo all’interno della comunità. Ed è proprio il corpo, ancora una volta, ad essere messo al centro. Bersaglio delle cure, (s)oggetto talvolta ingombrante. “Se sto bene – anche fisicamente – posso continuare a vivere nella comunità”, nella misura in cui posso continuare ad esercitare le funzioni genitoriali, posso continuare a ricoprire un ruolo lavorativo, posso continuare ad essere… ed è proprio in quel posso continuare – nonostante l’immagine si sé sia cambiata – che, come psicologi, come psicoterapeuti, dobbiamo lavorare. La nostra responsabilità è enorme nel garantire il benessere durante e dopo la cura. Ma per riuscire a garantirlo, è necessario considerare il mutamento culturale, che ha comportato e comporta un cambiamento dell’approccio della donna nei confronti del proprio corpo. Da un sondaggio condotto dalla Dott.ssa Fabi emerge come la maggior parte delle donne alle quali è stato diagnosticato un tumore al seno hanno fatto la mastectomia e come la maggior parte vorrebbero togliere entrambi i seni. La protesi è vissuta come qualcosa di esterno che entra nel proprio corpo.
Il tumore al seno SI VEDE. Il tumore SI SENTE. Il tumore abita e trasforma il corpo, l’immagine corporea, il sé dialogico.
Vissuto e sofferenza nella crisi, Patrizia Pugliese
Cosa accade a livello intrapsichico e relazionale quando il cancro irrompe nella vita del paziente?
Il cancro determina un evento stressante ad alto impatto emozionale perché porta i pazienti a confrontarsi con l’imminenza della fine. Li porta a dover fare i conti con la frattura della continuità delle esperienze di sé e del mondo, con la precarietà della propria esistenza, con la scissione importante tra corpo e processi di metallizzazione.
All’inizio gli incontri con pazienti che hanno ricevuto una diagnosi di patologia neoplastica sono incentrati sul corpo perché le metallizzazioni sono “intollerabili”, spiega la Dott.ssa Pugliese. La presenza di un evento così doloroso e radicale impatta sull’esistenza della persona e richiede un processo di riadattamento molto significativo. Gli esiti dei trattamenti impattano ulteriormente su numerose sfere di vita, facendo emergere l’esigenza di un lavoro d’equipe multidisciplinare: “dobbiamo imparare a lavorare insieme”.
Chi vive il cancro usa molto spesso la retorica delle “perdite”: si è perso quel che si era, il modo in cui si facevano le cose… e questo fa emergere sofferenza, paura, stanchezza, rabbia, demoralizzazione, senso di impotenza. Il disagio, il modo in cui viene gestito, interagiscono con altri elementi che caratterizzano la patologia neoplastica (tipo di malattia, prognosi, trattamenti) e gioca un ruolo rilevante nel produrre gli out come clinici in termini di aderenza ai trattamenti, tempi di recupero, sopravvivenza e probabilità di recidiva. La Dott.ssa Pugliese è entrata nel merito del costrutto di “immagine corporea”: uno degli elementi indispensabili per la formazione della propria identità personale e della nostra immagine del mondo. E’ stata da lei definita come la rappresentazione mentale che ognuno di noi costruisce nel corso del tempo in riferimento al nostro corpo e che interagisce con gli aspetti sociali e culturali. È importante conoscere come il malato percepisce il suo sé malato. Il corpo viene spesso vissuto come un luogo estraneo, “un corpo che ha tradito gli obiettivi che gli sono stati attribuiti per un funzionamento sano”. Inoltre, è un corpo destinato a cambiare ed il cambiamento è determinato anche dai trattamenti che si fanno. Rispetto a questi, vi è un significato soggettivo che le donne attribuiscono ai vari tipi di trattamento medico. Ad esempio, la principale criticità della chirurgia è l’accettazione di un nuovo corpo e le conseguenze di questo nelle sfere di vita sessuali, sociali. La chemioterapia può avere un impatto più distruttivo dal punto di vista psicologico (la perdita dei capelli, il gonfiore, il dolore…). La radioterapia è molto legata alle caratteristiche del trattamento, tuttavia, uno degli elementi comuni è l’insorgenza della fatigue che, nel suo manifestarsi, impatta sulle attività della vita. La terapia ormonale viene vissuta come problematica dalle donne più adulte in quanto sono costrette a vivere un corollario di sintomi che hanno già vissuto e al contempo a fare i conti le credenze della menopausa. D’altro canto, le donne più giovani, si interfacciano con un limite, la perdita della fertilità e dell’essere in grado di procreare. Ciò che emerge è la difficoltà di vivere una tappa di vita anagraficamente “fuori tempo”. Numerose ricerche mettono in luce che interventi di supporto psicologico orientati a migliorare l’immagine corporea e i significati ad essa attribuiti contribuiscono a facilitare l’adattamento alla malattia, a migliorare la relazione di coppia, a diminuire la fatigue e la paura di recidiva.
La conclusione dell’intervento della Dott.ssa Pugliese ha valorizzato la figura dello psicologo, come colui che deve essere presente nel core team degli operatori sanitari. “Abbiamo bisogno di avere spazi dedicati in cui ci si confronta e si arriva ad una scelta clinica costruita e condivisa con il paziente”.
Confini e nuovi scenari nei momenti di crisi, Maria Perrone
La Dott.ssa Perrone, riprendendo l’esperienza di interruzione delle continuità biografica ed esistenziale dell’individuo che riceve una diagnosi di cancro, ha chiesto:
“Cosa esce dallo sfondo per diventare protagonista di questa tragica esperienza?”. Il corpo.
Il corpo è la coloritura emotiva di tutte le nostre esperienze, anche sensoriali. L’afflizione che non trova sbocco nelle lacrime trova sbocco in altri organi, è una citazione usata per delineare il ruolo degli operatori sanitari nel favorire e promuovere un processo di espressione e descrizione dei propri vissuti. E’ proprio l’incontro con l’altro che riduce il rischio di frammentare l’immagine di sé e che accompagna il processo di mentalizzazione.
La Dott.ssa Perrone ha parlato di “clinica incarnata” e di campo terapeutico “intersoggettivo” per dare un valore di primarietà alla dimensione corporea in ambito oncologico.
SESSIONE III: Io ho un corpo, io sono un corpo e da qui riparto
L’empatia, questa sconosciuta, Anna Costantini
L’intervento della Dott.ssa Costantini ha posto al centro il costrutto di “empatia”, un termine che molto spesso usiamo senza alcun riferimento alle sue origini e al senso originario. Cosa caratterizza un comportamento empatico? Questo intervento ha rievocato in me l’approccio fenomenologico al costrutto di “empatia” di E. Stein e E. Husserl. “Einfühlung, un vissuto spontaneo che mette immediatamente in relazione una persona con un’altra. L’empatia, scrive Edith Stein “è un’esperienza di una coscienza altra da noi, indipendentemente dal tipo di soggetto che compie questa esperienza e dal tipo di soggetto la cui coscienza è sperimentata”. Tale esperienza presenta una certa peculiarità, in quanto in essa vi è una componente originaria e una non originaria. E’ originario l’atto del cogliere il vissuto altrui: “sono io che vedo la gioia nello sguardo degli altri”; non è originario il vissuto che empatizzo in quanto la gioia che la persona esperisce gli appartiene. Se così non fosse si tratterebbe di “unipatia”, sostengono i fenomenologhi.
Ogni giorno incontriamo utenti, colleghi, familiari. Ogni giorno ci troviamo a modulare, gestire, governare il nostro e l’altrui mondo emotivo. La gestione delle emozioni è una parte integrante del lavoro in ambito di salute e di sanità e “non esiste comportamento empatico che non passi attraverso al nominazione dell’emozione del paziente”, sostiene la Dott.ssa Costantini. “Bisogna nominare l’emozione. Quando l’altro riconosce un’emozione che noi in qualche modo non avevamo codificato, ci sentiamo compresi”. Ascoltare non basta. In che consiste l’ascolto empatico? Nell’essere attenti ai bisogni e alle peculiarità delle narrazioni prodotte dalle persone che incontriamo. Questo è il primo passo per poi scegliere quali parole usare e per innescare un “dialogo empatico”.
Trasformazione del corpo e recupero del Sé nel fine vita, Rosangela Caruso
La Dott.ssa Caruso ha letto le parole di una paziente che ha seguito per molti anni per mettere in luce come la trasformazione del corpo che la malattia impone può essere un’occasione per ritrovare sé stessi. “Quando ci si ammala, quando si vive un’esperienza traumatica come malattia e soprattutto del fine vita si ha la possibilità di modificare l’interazione con sé e con gli altri. La sfida ultima è quella di approfondire la concezione della vita, comprendere quali sono le proprie priorità, scegliere a cosa e chi dedicare il tempo”. Il prof. Rodin parla di doppia consapevolezza: sentirsi particolarmente vivi proprio nel momento in cui si sente che la vita sta sfuggendo via. I terapeuti, sostiene la Dott.ssa Caruso, hanno il compito di aiutare i pazienti a non sentirsi vittime di un fatto tragico ma di essere individui che stanno attraversando un momento difficile e che possono riconoscere ed esplorare le proprie risorse.
In barca a vela contromano. Un viaggio verso il recupero del proprio spazio e progetto di vita, Tiziana Raimondi Ragni
“In barca a vela contromano” è il titolo di un gruppo di psicoterapia.
La malattia mette in crisi il corpo e mette in crisi la nostra soggettività, la possibilità di conoscere, fare esperienza del e nel mondo. “In questo momento di frattura creato dalla malattia quante volte ci siamo sentiti in barca a vela contro mano?” ha chiesto la Dott.ssa Ragni. E ha continuato: “Ma quando una barca va contromano rischia di frantumarsi. Allora cosa si deve fare? Deve entrare nel vento!!”. Far entrare il vento è il contributo degli operatori che si occupano della salute degli individui: entrare nel vento, nelle trame di vita, per poter attivare una ripresa di vita.
I primi incontri di gruppo, racconta la Dott.ssa Ragni, si caratterizzano per la presentazione di sé che di fonde con la malattia che è stata diagnosticata: l’identità è la malattia. La presenza nei primi incontri viene giustificata dalla narrazione comune “sono qui perché so che tu mi capirai senza necessariamente dover parlare. Solo chi ci è passato può capire”. Il confronto si sa, apre alla possibilità di essere compresi. Negli incontri centrali emerge la paura e l’angoscia: esplode una rabbia nei confronti dei medici e di coloro che non hanno il cancro. Affianco alla costante retorica della comprensione e della condivisione, si affaccia un mito: il tempo dell’impotenza. “Prima potevamo fare tutto e adesso niente”. La condivisione e il lavoro su questo mito fa rendere loro conto che qualcosa si può fare. Ad esempio, si può pensare all’estate malgrado la stanchezza. Nel corso degli incontri centrali, spiega la Dott.ssa Ragni, accanto all’unica possibilità di “essere” la malattia, emerge la possibilità di “avere” una malattia. Il passaggio dall’essere all’avere è un processo da curare: ciò che ho non mi connota nella mia essenza.
Tra il paradiso del prima e l’inferno del dopo si apre lo spazio del durante. Si apre la possibilità di parlare del cancro in terza persona.
Nel corso degli ultimi incontri, le voci iniziano ad avere ed assumere un ritmo diverso. Cambiano le domande: chi partecipa si chiede quanto tempo ha per dire delle cose anziché chiedersi quanto tempo ha ancora da vivere. E’ possibile che alcuni cambino il senso attribuito alla stanchezza, alla fatica: dall’essere un effetto collaterale diventa un prodotto del fare le cose e affrontare la situazione.